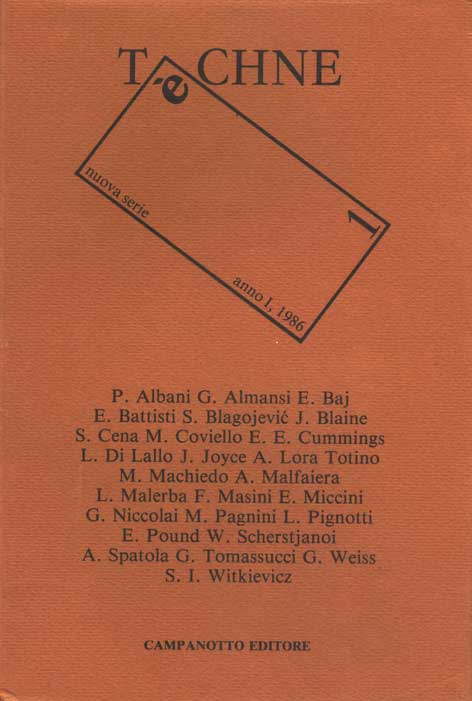Eugenio Battisti
LETTERA A TèCHNE
Come dare il benvenuto ad una
nuova rivista, dichiaratamente di avanguardia?
Ricordando che nessuno è profeta in patria, e che quindi bisogna
subito evadere da una provincia mascherata di cultura e tradizione, e
puntare
con il cannocchiale altrove, verso l'eresia? Ma dove si trova l'eresia,
oggi, quando tutti, per disperazione o per stanchezza, ci siamo messi a
lavorare con e dentro le istituzioni? E che significa essere eretici
quando
le teorie, anche nostre, dileggiate e combattute diventano dopo venti
anni
oggetto di moda e perfino di celebrazione? 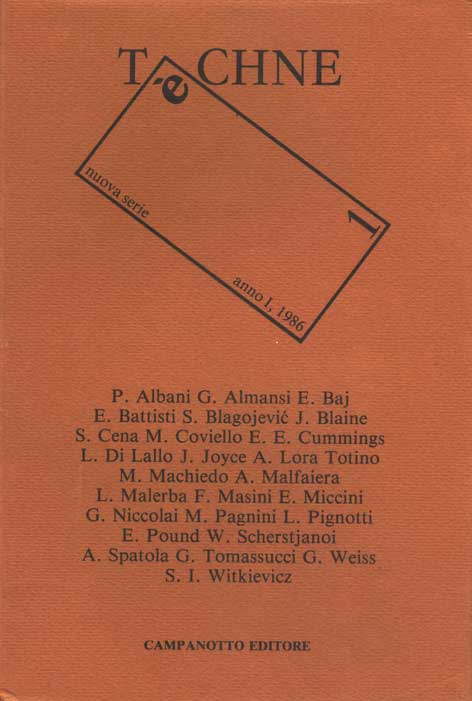
Quello che mi pare manchi è l'aggressività spontanea,
del ragazzo beneducato ma represso, che per puro istinto, con violenza
inattesa, si butta sulla sua strada. Questo tipo di ragazzo era
d'altronde
una eccezione sociale, in quanto credeva in valori che lo impegnassero
a tempo pieno in qualcosa di socialmente essenziale ma economicamente
improduttivo,
e poiché era guidato dall'istinto aveva terribili angosce e
perplessità.
Il vietato oggi non esiste più; nessun padre si arrabbia se il
figlio
suona la chitarra o scrive poesie, la società del consumo
assorbe
tutto, e amalgama. Mimetizzati dal loro stesso grande numero, e non
più
indicati a dito, gli scrittori insegnano all’università, i poeti
lavorano nelle case editrici o negli uffici stampa delle industrie, e
così
via per tutti gli altri mestieri. Fa scandalo in una cultura come la
nostra
che fortunatamente non ha più inibizioni sociali e culturali, e
assai poca censura, non l'emarginazione, ma caso mai l'insuccesso
economico;
non la voglia matta di cercare una via inconsueta in fratellanza, in
certo
senso magica e non programmabile con chi pensa alla stessa maniera, ma
l'incapacità di farla diventare uno scoop giornalistico. Tutto
cede
e si arrende, almeno a livello di programma e di intenzioni, e ci
dibattiamo
quindi in una gabbia di ovatta.
In realtà la linea fortificata contro cui combattere, ed a cui
forse il nome della rivista si riferisce, non appare immediatamente
all'orizzonte
ed è preceduta da innocui fossatelli e terrapieni. Ma è
talmente
solida e massiccia, quando la si scopra, da richiedere non l'azione
sparuta
di un piccolo gruppo, ma un immenso impegno collettivo, variamente
articolato.
Non è più operabile, come ai vecchi tempi, un'azione di
punzecchiamento
per fare infuriare il toro, cioè una massa ritenuta per sua
natura
inerte ed esplicitamente conservatrice; vanno sostituiti invece
completamente o quasi gli apparati dirigenziali compiendo una vera e
propria
scalata al potere; non c'è più il rifiuto teorico delle
novità
ma la difficoltà, l'impossibilità di realizzarle o di
acquisirle,
e la posta in gioco non è lo svecchiamento delle idee, compiuto
magari con provocazioni e gesti beat, ma tout court la
sopravvivenza
della civiltà occidentale e dentro di questa dell'Italia, contro
un blocco che non è ideologico, ma burocratico, e dilaziona ogni
indispensabile mutamento a tempi infiniti, sia nelle strutture statali
che in quelle private, dichiarando invece pubblicamente di stare su
posizioni
di avanguardia. È la solita storia delle piccole società
inventive e di punta, acquistate dai monopoli appena diventano
pericolose
per infossarle e farle tacere. 
Inoltre mentre un rapido consumo non fa male alla cultura, in quanto
provoca continue trasformazioni e mette in moto quel grande fenomeno di
consumo
collettivo che sono le mode, esso è un'autentica tragedia per
l'industria
e per i programmi finalizzati. Fare e volere il nuovo richiede
progettazione,
sperimentazione, impegno e capacità di affrontare il rischio,
anzi
di procedere per molte tappe alla cieca: non si può sapere
ciò
che ancora non si sa, non si può pianificare ciò che non
è ancora definito, nessun calcolatore può computare
ciò
che non si sospetta ancora che possa accadere. Un'attitudine dadaista,
magari aiutata da modelli economici e matematici, dovrebbe diffondersi
anche nel mondo produttivo, a correttivo della miopia decisionale che
oggi
prevale.
Bisognerebbe però scrivere in proposito su giornali finanziari,
ed essere altre razze di esperti.
D'altronde il tipo di raffinata rivista per pochi lettori, di dieci,
venti anni fa sta per essere cancellato come via di comunicazione,
dalla
posta elettronica; anche la stampa tradizionale ha i mesi contati;
volendo
convocare per un dibattito i pochi amici che contano si ha tutto il
mondo
a portata di selezione telefonica automatica; eppure - proprio come
capita
quando ti regalano il floppy d'un complicatissimo programma senza il
manuale
operativo, mai si è avuto una tanto grave impressione di
disgregazione
culturale. Ciascuno si è abituato (o rassegnato) ad andare
avanti
per conto suo.
Si cozza contro difficoltà di struttura che prima non
esistevano,
in quanto - ripeto - non si tratta più di fare una guerriglia,
ma
una guerra vera e propria, e non si sa neppure sotto quale bandiera
politica
issare il campo.
Quello che mi scrivete è purtroppo esatto. "La ricerca, il
moderno,
sembrano sterili affluenti di se stessi. La citazione coltiva i campi
incolti.
Il 'post' è anteposto a tutto." Ciò che si ottiene dai
collaboratori
sono "accenti circonflessi sul buio e sulla morte".
Avete scelto male il vostro presentatore. Anch'egli ha ormai la
vocazione
per questi accenti. Anzi appena eccitato dagli amici, come un maldestro
deltaplano sballottato da un vento traverso, egli si mette liberamente
non a far dell'ironia, ma a tirar giù bestemmie, per esprimere
tutta
la sua rabbia. Ve la dovete dunque cavare da soli, con le vostre forze
e, soprattutto, la vostra fortuna. Specialmente se i bioritmi del luogo
dove la rivista sorge tendono al peggio. Una pubblicazione di gruppo,
infatti
per quanto con il telefono e la posta, si smaterializzi come sede,
richiede
ed alimenta un certo consenso sociale, è insomma come il nucleo
solido d'una cometa che nella sua corsa attrae a mo' di coda infinite
particelle.
Sarà mai possibile operare questo tipo di aggregazione in
Toscana,
dove uno dei proverbi che corrono è che le società devono
avere un numero di soci dispari ma in tre si è già
troppi?
La mia speranza è sì.
Firenze, tecnicamente debole, ma intellettualmente capace può
formulare un modello intermedio fra quasi modernità di sviluppo
ed inerzia da terzo, o quarto mondo, mettendolo a servizio di un
aggiornamento
generale della società italiana, non solamente elitario. Me ne
dà
fiducia anche il fatto che subito abbiate depennato la retorica, nella
prima pagina della nuova serie di Tèchne. Ma date un
significato
analogamente non retorico a "poesia", "letteratura", "arti".
La posta in gioco ormai è globale, altrettanto economica che
tecnologica che "culturale" in senso ristretto, giacché
c'è
solo più una scacchiera, quella del software dove si giocano
tutte
le carte, e non importa che seme o che colore abbiano. Rimangono
però
ancora trionfanti gli assi e le regine, cioè il sapere ed il
volere di
più.
Nella situazione ultimissima le grandi operazioni culturali possono
essere fatte solo più a due livelli: quello del massimo
prestigio
(che non significa però accademia) e quello della ribellione da
minoranza, rabbiosa e combattiva, costretta prima a difendersi
dall'annientamento,
poi a riconquistare qualche piccolo spazio, proclamando su di esso i
propri
diritti in tutte le occasioni e ad alta voce. Il ruolo di portavoce di
una sparuta minoranza, è quanto auspico a Tèchne.
La minoranza, che si sente per definizione esclusa, e quindi creditrice
di stima e di attenzione, è legittimata a proporre ad alta voce,
in modo che tutti si scoccino, l'inaccettabile; a compiere gesti duri,
scortesi; a distinguere, magari artificiosamente, fra un presunto bene
ed un presunto male, marchiandoli con segni vistosi di consenso e di
ludibrio,
a far pettegolezzi, ironie, sarcasmi, sempre ad alta voce.
Insomma, dopo tante chiacchiere, la conclusione è ovvia: a mio
parere bisogna rifare il Burchiello.
da Tèchne,
1, 1986, pp. 8-11.
Home page Archivio
cartaceo
|